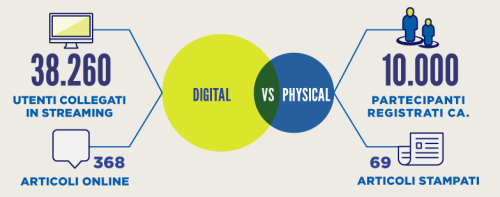A seguito del mancato rinnovo dell’accordo Rai-Google, da domani 1 Giugno spariranno da YouTube tutti i video ufficialmente pubblicati da Rai (parecchie migliaia di clip). Sempre da domani, la Rai potrà chiedere la rimozione delle migliaia di propri video pubblicati dagli utilizzatori di YouYube, quasi tutto materiale d’archivio, e sui quali (proprio in virtù di quell’accordo) Google – grazie al sistema ContentID – riconosceva alla tv pubblica italiana una quota di ricavi in base alle views di ogni clip.
Cosa succederà adesso? Il materiale “nuovo”, che poteva essere consultato sui canali ufficiali Rai di YouTube, migrerà sull’ottimo portale Rai.tv, senza – almeno così assicura l’azienda radiotelevisiva di Stato – che vi sia alcun “cono d’ombra” durante questa complessa transizione. Credo si debba avere molta fiducia su questo, nel senso che si tratta della quota di contenuti su cui Rai spera di recuperare molta raccolta pubblicitaria gestendola in-house e finalmente sottraendola al sistema di Google.
Il materiale d’archivio invece, in stragrande maggioranza pubblicato su canali non ufficiali (quindi illecitamente) su YouTube, sarà verosimilmente rimosso su richiesta della stessa Rai, proprio come accade ormai da molti anni con le clip catturate da Mediaset.
Ora, nel cercare di elaborare un giudizio – positivo, neutro o negativo – su questa scelta, non credo sia il caso di snocciolare numeri. In fondo, tutto dipende da Google, e non conosciamo i termini che hanno fatto naufragare la trattativa per il rinnovo. Forse se avessero negoziato una quota più alta oggi non staremmo nemmeno a commentare questo esito.
Credo che sarebbe scorretto anche fare della dietrologia, per esempio immaginandosi un Gubitosi costretto a mandare un segnale di “austerità e delivery” al Governo, resosi necessario dopo il taglio di 150 milioni di euro paventato dall’esecutivo.
Però su una cosa credo sia opportuno spendere qualche considerazione: se per quanto riguarda i canali ufficiali e i materiali “nuovi” (diciamo dell’ultimo anno) mi pare giusto immaginarsi una azienda pubblica fatta di manager che devono compiere scelte strategiche per far quadrare i conti, diverso – molto diverso – è il discorso per la massa di quei capture illeciti di materiali “vecchi”, sui cui Rai non riesce a monetizzare granché.
Il modello della raccolta pubblicitaria online attualmente perseguito da Rai.tv si fonda infatti su “ciò che va per la maggiore”, e cioè “ciò che adesso va in televisione”: le dirette streaming, la catch-up tv dell’ultima settimana, le clip più interessanti, dove impera ormai da anni sua maestà lo spot in pre-roll. Bisogna dire che si tratta di una strategia del tutto ragionevole, perseguita con intelligenza da persone che ne sanno, cercando di proporre la miglior user-experience possibile sia sul sito sia sull’applicazione Rai.tv, non a caso una delle più scaricate in Italia.
Ma tutto il resto? Quanti soldi, e come intende farli Rai.tv con le vecchie puntate di StudioUno, con l’integrale della diretta per la conquista della luna del 1969, coi telegiornali del rapimento Moro, con tutte quelle cose – per intenderci – che oggi si possono ancora trovare su YouTube e domani, anzi tra pochi minuti, verosimilmente inizieranno a sparire?
Spiace dirlo, ma io credo che la Rai non abbia una vera strategia per monetizzare questi contenuti, e consideri una specie di incidente il fatto che oggi i video su YouTube siano le vere “teche”, la vera memoria collettiva del Paese. Ed è un peccato, perché è proprio grazie a YouTube che oggi molti giovani italiani possono sapere cos’è stata la Rai prima di diventare, per qualche disgraziata evoluzione politica, una brutta copia di Mediaset senza che ve ne fosse alcun obbligo nè economico nè istituzionale (anzi). Prima dei “meravigliosi” anni ’80 la Rai era una straordinaria fabbrica di idee, cultura, informazione, intrattenimento di prim’ordine a disposizione di tutti. E se a disposizione di tutti lo era rimasta lo si doveva proprio alle formichine che su YouTube catturavano quei vecchi programmi e li ripubblicavano certo non per fine di lucro.
Ma sono davvero queste vecchie trasmissioni, sono questi pezzi di storia i colpevoli di quel furto di attenzione nei confronti di Rai.Tv, o – peggio – dell’intoccabile schermo del salotto minacciato dalla Chromecast? E’ per colpa di una YouTube dove puoi trovare Mina e Alberto Lupo, le commedie di Eduardo, i supplementari di Italia-Germania 4-3 che la Rai “sta perdendo ricavi”?
Ovviamente no. Nonostante le ossessioni di chi lavora nella incrollabile logica del broadcaster, chi studia gli user behavioural trends sa che i veri responsabili di questo furto sono da cercarsi altrove: su Facebook, su Whatsapp, persino su Candy Crush. E su milioni di altri schermi che, fregandosene della Rai e molto spesso anche di YouTube, governano sempre più la vita in salotto, in cucina, in camera da letto, in tram, in ufficio, ovunque. E’ per le tante altre cose che succedono su questi schermi, che solo in minima parte o comunque per altri versi hanno a che fare con “la televisione”, che guardiamo sempre meno “la televisione”.
E’ buffo perché vedete, nel fare questi discorsi, ci sto cascando anch’io. Sto discutendo del modello di una televisione che sarebbe di tutti (la Rai) come se fosse la televisione di uno solo (Mediaset), mettendo direttamente in relazione lo stesso modello di business (la raccolta pubblicitaria, la pay-tv) come se non esistesse un contratto di servizio, come se la Rai non avesse appunto proprio quel ruolo, cioè quello di usare tutte le tecnologie disponibili per ricordarci chi siamo, come eravamo e dove potremmo quindi decidere di andare.
Le scelte di altri grandi operatori di televisione pubblica in Europa ma anche nel resto del mondo, da sole, dovrebbero dirci a sufficienza quanto sia miope trattare l’argomento mettendola su un semplice piano di confronto di strutture di costi e ricavi.
Ora, non è difficile immaginarsi che qualcuno a questo punto possa obiettare “e allora che facciamo, chiudiamo la Rai, o la privatizziamo come in Grecia, visto che i soldi per tenerla in vita sono finiti?” La domanda è legittima, ma è come se arrivasse da un canguro che sta per affogare per aver voluto sfidare a nuoto un delfino, invece che a salto in lungo, e non si vede perché debbano essere i diritti (eh sì, sono “diritti”) dei cittadini a doverne pagare le conseguenze. La vera domanda è: quanto è disposto il Governo a far rinascere la Rai, a farla tornare ad essere una risorsa per il Paese al servizio di quella economia della conoscenza di cui proprio nei proclami governativi si parla di continuo?
E per quanto siano ridicoli gli appelli, specie quando arrivano da un semplice blog come questo, allora forse è il caso di chiedere a chi – per legge e per conto nostro – concede a questa azienda l’incarico di svolgere un servizio pubblico (ah, quanti termini vintage), di fare due semplici cose:
- chiedere alla Rai di studiare e mettere in atto una efficace strategia di monetizzazione, con tutti i mezzi disponibili, dei contenuti “nuovi” su Rai.tv e sulle altre proprie piattaforme in modo da contribuire in modo decisivo al salvataggio e al rilancio dell’Azienda;
- imporre alla Rai di rinunciare a far rimuovere i contenuti “vecchi” da YouTube, così da salvaguardare l’unico vero archivio naturale dell’azienda seriamente accessibile al pubblico, che dà lustro alla storia della prima industria culturale del Paese e non minaccia in alcun modo i modelli di business attuali.
Chiedo troppo? Non lo so, ma non potevo star qui ad assistere impotente allo stacco della spina. Almeno non avrò il rimpianto di non averci provato.