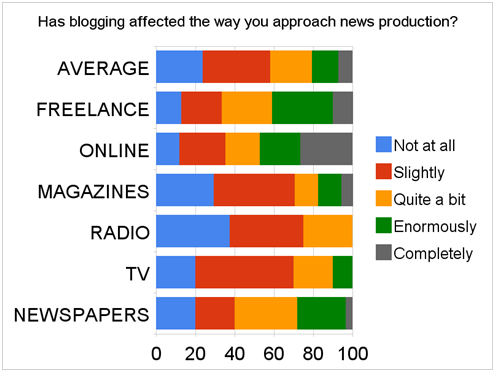Seguo da qualche giorno, non senza un certa perplessità, i termini della polemica sul “possibile dialogo” tra HTML5 e moduli DRM. La faccio breve, i tecnici mi scuseranno: si tratta di un progetto del W3C, l’organismo preposto a determinare l’evoluzione dei Web Standards, per permettere ad HTML5 di dialogare con componenti esterne per la gestione dei diritti digitali, in modo da consentire la visualizzazione nel browser di contenuti protetti.
Dato il brodo culturale in cui è nato il progetto HTML5, in opposizione a piattaforme proprietarie come Flash e Silverlight, non era difficile prevedere la levata di scudi di tutto il movimento Open nei confronti del W3C. Esso infatti si oppone per principio all’idea stessa di condizionare l’accesso a un “subset” dei contenuti disponibili sul web, e quindi – per usare un eufemismo – non vede di buon occhio le tecnologie che rendono possibile questa pratica.
Ancor più prevedibile è che alla testa di questa reazione che – senza alcuna connotazione dispregiativa – potremmo definire “ideologica”, si ritrovi Richard Stallman, a cui l’intero movimento deve molto per la forza della sua voce su fondamentali questioni di principio in momenti ben più critici di questo.
All’attuale grado di evoluzione del dibattito mi sembra però di poter dire che questi timori siano più che altro legati all’idea che si verifichi una certa previsione “balistica”, quella secondo cui questa scelta costituirebbe solo il primo passo verso l’integrazione forzata del DRM all’interno dei sistemi operativi. Un vero e proprio “turning point” dunque, che facendo breccia nella “città proibita” della Open Internet (il browser, e non le applicazioni per intenderci) finirebbe per inquinare l’intero ecosistema Open.
La mia impressione è diversa. Intanto, mi pare un po’ strano che un movimento che si professa “Open” fondi una sua presunta strategia difensiva sulla necessità di non dialogare con dei “pezzi di codice”, anche se questi servono a una certa industria per rendere economicamente sostenibile la distribuzione di alcuni contenuti.
E poi, mi verrebbe da pensare, quale sarebbe l’alternativa? Secondo Peter Bright se le major e i broadcasters fossero tenuti fuori da uno standard codificato ne creerebbero uno “de facto”, come sempre accaduto in passato. E il browser perderebbe proprio quel crescente ruolo di protagonismo agnostico e trasparente su tutti i “connected screens” che rende straordinariamente potente l’intero progetto HTML5. Chrome e Firefox, per fare un esempio, perderebbero la capacità di fare concorrenza su tutti i connected devices agli App Stores, cioè quegli ambienti protetti dove gli utenti hanno già dimostrato una notevolissima disponibilità a pagare contenuti, non percependo il valore di una alternativa a quel tipo di ecosistema.
In definitiva, decidere di non dialogare con chi, nel proprio (morente) modello di business, vede il DRM come l’unica soluzione, al di là della rivendicazione identitaria e della scelta ideologica, non porterebbe alcun vantaggio, ma solo l’enorme svantaggio di rendere ancora più complessa la già non semplice operazione di “popolarizzare” il movimento Open. Che non riguarda solo il codice, ma anche i dati, i contenuti, la shared culture e tante altre cose interessanti di cui parleremo il 5 giugno all’Open Camp a un pubblico il meno autoreferenziale possibile.
Tra l’altro, per chiudere il cerchio, anche il questo caso i grandi brand che sponsorizzano il progetto del W3C, e in particolare Google, Netflix e Microsoft, stanno palesemente usando ancora una volta la bandiera del DRM per tranquillizzare le major, proprio come fece a suo tempo Apple con iTunes. Ma non possono essere così sprovveduti da non sapere (come ben racconta ManuSporny – e grazie ad Alessio Biancalana per la segnalazione) che per chi vorrà pervicacemente craccare questi moduli l’operazione non porrà particolari difficoltà tecniche. Sulla scorta della mia memoria storica, potrei aggiungere che ancora una volta il DRM viene ipocritamente utilizzato come foglia di fico per vendere internamente alla vecchia industria l’evoluzione verso una nuova forma di distribuzione dei loro contenuti, e con essa una minima prospettiva di sostenibilità economica.
Ma il terreno dello scontro tra nuovo e vecchio ecosistema non potrà certo essere quello dell’incomunicabilità forzata dei protocolli e dei linguaggi. Piuttosto, occorrerà far fare al tempo il suo mestiere di galantuomo. Grazie al browser (ma anche grazie alle Desktop Apps in HTML5) e più in generale grazie alle piattaforme di distribuzione aperte, le nuove generazioni avranno comunque un crescente accesso a un ecosistema di contenuti indipendenti. Questi ultimi, come ebbi modo di dire nel corso di un panel sui trend emergenti in occasione dell’ultima Social Media Week, potranno quindi trovare autonomamente i loro modelli di sostenibilità liberandosi di tutti gli elementi che trattengono il valore, remunerando sempre più la creatività (del contenuto ma anche del modello) e sempre meno chi si mette in mezzo a far pagare qualche inutile pedaggio.
Questa, secondo me, è la strada. Il resto sono solo battaglie identitarie che anche troppi danni hanno già arrecato in passato.