 Questo weekend sono venuti a trovarci a Roma degli amici fiorentini. Colti da un diluvio in centro, abbiamo deciso di percorrere un tratto di questo gioioso sabato capitolino in metropolitana. Era la scelta più intelligente, sia per non bagnarsi, sia per evitare di rimanere imbottigliati. Al momento dei saluti, uno di loro mi ha colpito per due giudizi drammaticamente veri sulla nostra città. Da un lato le consuete lodi sperticate per le bellezze artistiche: in questo caso l’aspetto drammatico è che ormai, invece di inorgoglirci, allarghiamo le braccia come a scusarci del fatto che siano così scarsamente curate, fruibili o anche solo raggiungibili. Dall’altro lato, un giudizio sulla metropolitana: non “scadente”, “malfunzionante” o “degradata”. Ma “buia”. Sì, proprio “buia” rispetto alle analoghe infrastrutture di Londra, Parigi, Berlino, Madrid, che possono contare su una rete infinitamente più ampia e capillare. Forse noi che ci abitiamo, che la usiamo tutti i giorni, questa oscurità finiamo per darla per scontata, come se la metro fosse qualcosa da nascondere, una sorta di “male necessario”, quasi una catacomba moderna. O forse c’è qualcosa di più?
Questo weekend sono venuti a trovarci a Roma degli amici fiorentini. Colti da un diluvio in centro, abbiamo deciso di percorrere un tratto di questo gioioso sabato capitolino in metropolitana. Era la scelta più intelligente, sia per non bagnarsi, sia per evitare di rimanere imbottigliati. Al momento dei saluti, uno di loro mi ha colpito per due giudizi drammaticamente veri sulla nostra città. Da un lato le consuete lodi sperticate per le bellezze artistiche: in questo caso l’aspetto drammatico è che ormai, invece di inorgoglirci, allarghiamo le braccia come a scusarci del fatto che siano così scarsamente curate, fruibili o anche solo raggiungibili. Dall’altro lato, un giudizio sulla metropolitana: non “scadente”, “malfunzionante” o “degradata”. Ma “buia”. Sì, proprio “buia” rispetto alle analoghe infrastrutture di Londra, Parigi, Berlino, Madrid, che possono contare su una rete infinitamente più ampia e capillare. Forse noi che ci abitiamo, che la usiamo tutti i giorni, questa oscurità finiamo per darla per scontata, come se la metro fosse qualcosa da nascondere, una sorta di “male necessario”, quasi una catacomba moderna. O forse c’è qualcosa di più?
Lo sappiamo bene: il servizio di trasporto pubblico a Roma non è solo insufficiente, ma è persino indegno di una grande capitale: In particolare, di una metropoli che gioca sulla fruibilità del suo patrimonio culturale la sua unica possibilità di trovare una proposizione di valore durevole e sostenibile, dopo aver perso la scommessa industriale prima e dei servizi poi. Ma attenzione all’equivoco in agguato: questo non significa che il servizio in sé sia inutile. In molti casi, in base agli orari e alle zone di partenza e di arrivo, persino la sgangheratissima rete Metrebus può risultare competitiva col mezzo privato, specialmente quando le zone in questione sono collegate da una o più linee su ferro.
Prendiamo la tratta Balduina-Trastevere: in quasi tutti gli orari (con l’eccezione delle sere dei giorni feriali) per arrivare in tempi certi a destinazione conviene prendere il treno metropolitano della FR3 (da Balduina a Trastevere), con frequenze di 12 minuti, e poi il Tram 8. Eppure vediamo pochissime persone salire a bordo dei treni FR, che continuano ad essere frequentati soprattutto da pendolari. E lo stesso può dirsi, anche se in misura minore, per la buia metropolitana e i tram, che rimangono il regno di turisti, extracomunitari e studenti squattrinati. In sintesi: il mezzo pubblico si prende perché non si ha la macchina. E anche lo scooter – coi suoi vantaggi e svantaggi – è largamente preferito, specie lontano dai mesi invernali.
Dopo molti anni in cui risiedo a Roma, sono giunto alla conclusione che una buona parte dei “mancati passeggeri” non ha molto a che vedere con la scarsa qualità del servizio, ma vada imputata piuttosto alla sua comune percezione come “luogo buio”, e quindi – sostanzialmente – una cosa da sfigati. Il ciclo è semplice: il servizio è pessimo (per quanto a volte concorrenziale), le vetture e le stazioni indecorose, la gente pensa che è una cosa da sfigati, l’ATAC e Trenitalia hanno un infallibile alibi per farlo funzionare sempre peggio, quando non per trasformarlo in un by-product (per le ferrovie, tutte prese ad investire nelle “Frecce” a lunga percorrenza) o un addirittura un side-business (per l’ATAC, e qui ci viene in soccorso la cronaca giudiziaria degli ultimi mesi).
Nel frattempo, nessuna campagna di comunicazione istituzionale ha mai nemmeno provato a colmare il gap tra percezione comune e percezione desiderata. Si tratterebbe di illuminare (fisicamente, ma anche metaforicamente) la parte competitiva della rete di trasporto pubblico, e cioè la rete su ferro. Malfunzionante, insufficiente quanto vogliamo, ma – come mostra la mappa qui sopra – tutt’altro che irrilevante, coprendo quasi tutte le aree strategiche della città con mezzi che viaggiano su sede propria, quindi indipendenti dal traffico delle auto. Essa comprende:
- le due linee della metropolitana A e B, che collegano quattro periferie popolose (Il Tiburtino, Montesacro, il Tuscolano e Primavalle) col centro rinascimentale, il centro archeologico e l’EUR – cioè il principale polo direzionale.
- le tre ferrovie concesse, che collegano le principali stazioni a tre borgate popolosissime (Ostia, Giardinetti e Prima Porta)
- le otto linee FR, di cui almeno due (la FR1 Fiumicino-Fara Sabina e la FR3 Cesano-Ostiense) con frequenze da servizio urbano, cioè di 12-15 minuti
- la rete tranviaria, che ha ripreso faticosamente a crescere negli ultimi 20 anni dopo un lungo letargo, tornando a 6 linee per una estensione totale di 42 chilometri, quasi tutti su sede propria.
Si tratta di ciò che rimane, al netto dei troppi ridimensionamenti in corso d’opera, della famosa “cura del ferro” introdotta da Walter Tocci negli anni della Giunta Rutelli. Una iniziativa che mirò a sfruttare al massimo i binari esistenti attraverso l’integrazione dei servizi, che divennero fruibili con un solo biglietto urbano nel territorio del comune, cambiando le abitudini di centinaia di migliaia di cittadini.
Oggi come allora, si tratta anzitutto di indurre un nuovo “cambiamento di abitudini”. Roma è una città dove i comportamenti collettivi sono spesso legati a una sorta di “sentire comune”, e basta davvero poco per invertire la tendenza. Senza scomodare i cicli di pubblico allo Stadio (metà classifica = stadio vuoto, alta classifica = immediato pienone anche quando si affronta una provinciale), vengono in mente fenomeni di più ampio respiro.
Nel bel mezzo dei molto bui anni di piombo, fu sufficiente animare le piazze con attività di cultura e intrattenimento per sconfiggere la paura della notte, come accadde con l’Estate Romana inventata da Renato Nicolini. Più di recente, bastò costruire una singola pista di pattinaggio su ghiaccio (a Mentana!) per vedere l’intera città letteralmente costellata, nel giro di pochi anni, da decine di piste coperte e scoperte, per il sollazzo di grandi e piccoli. Infine, ci volle l’inaugurazione dell “Case” (una decina di immobili sottoutilizzati e ridestinati dal Comune ad attività culturali negli ultimi anni), per riempire nuovamente il calendario di numerosi piccoli e grandi eventi dedicati al cinema, alla musica, al teatro, ai libri. Spesso con meriti persino maggiori rispetto ai grandi luoghi deputati alla produzione e all’aggregazione della cultura, come il MAXXI, il Macro e l’Auditorium.
Non si vede perché alla regola del “punto critico”, per dirla alla Malcolm Gladwell, debba fare eccezione l’abitudine al trasporto pubblico.  Sono convinto che anche prima del pur necessario salto di qualità dell’offerta, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione al funzionamento e al decoro dell’esistente per aumentare i “passeggeri paganti” (perché c’è anche un notevole problema di evasione da risolvere). Si creerebbero forse così le condizioni – in un secondo momento – per una crescita strutturale dell’offerta complessiva, che per quanto mi riguarda potrebbe tranquillamente ricalcare il Piano Sciarra di recente pubblicazione: Linea C, chiusura dell’anello ferroviario, aumento delle frequenze su tutte le linee FR, nuove linee tranviarie su alcune tratte chiave.
Sono convinto che anche prima del pur necessario salto di qualità dell’offerta, sarebbe sufficiente una maggiore attenzione al funzionamento e al decoro dell’esistente per aumentare i “passeggeri paganti” (perché c’è anche un notevole problema di evasione da risolvere). Si creerebbero forse così le condizioni – in un secondo momento – per una crescita strutturale dell’offerta complessiva, che per quanto mi riguarda potrebbe tranquillamente ricalcare il Piano Sciarra di recente pubblicazione: Linea C, chiusura dell’anello ferroviario, aumento delle frequenze su tutte le linee FR, nuove linee tranviarie su alcune tratte chiave.
Non ho la pretesa che i responsabili della comunicazione delle nostre aziende municipalizzate, sicuramente distratte da ben più gravi avvenimenti, mi stiano leggendo. Ma credo che sottolineare la competitività del trasporto pubblico su alcune direttrici essenziali e rendere più attraente quello che c’è, piuttosto che fantasticare di Metro D, E ed F, sia davvero, in questo momento, la tessera chiave del puzzle. Il resto, ovviamente, richiede investimenti e volontà politica, ma rinunciare all'”investimento emotivo” nel cambiamento da parte dei cittadini sarebbe a mio parere un errore imperdonabile. Per provare ad avere nei romani, per una volta, degli alleati, e non un popolo di eterni disillusi, al ritornello di “tanto non potrà cambiare mai niente”.

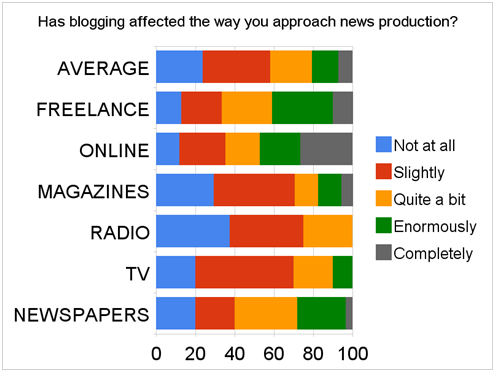
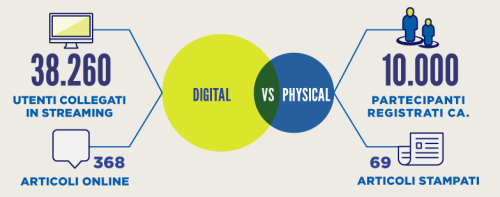
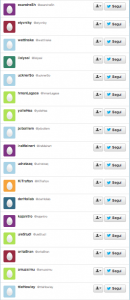



 Download MP3
Download MP3